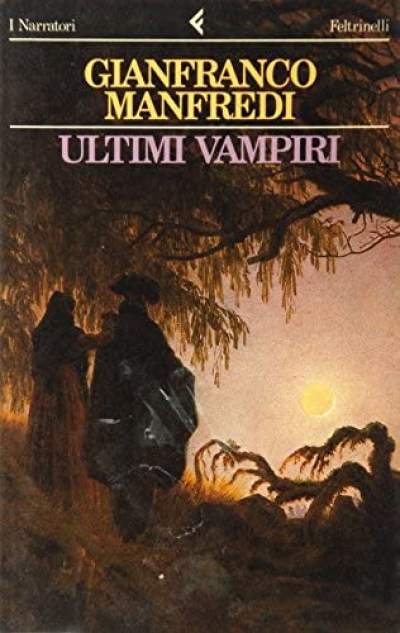Esplorare oggi quel labirinto di testi è impresa da far girare la testa, servono molti soldi e parecchio tempo a disposizione. Qualcuno in questi anni ci ha provato, altri ci proveranno. Personalmente, come accenna Giuseppe Tardiola in un paio di righe, quel ventennio ha pesato come pochi sui contenuti formali del genere, influenzando - anche in modo inconsapevole - tutta la narrativa successiva. Negli anni ’70 e nei primi ’80 si assiste a una progressiva dissoluzione di quell’impero fantastico. Daniele Bertusi (1997) in altre poche e dense pagine ci informa come il panorama letterario italiano di fine ’70 e primi anni ’80 sia già completamente diverso: le influenze americane variano da un horror psicologico e dal taglio fortemente realista come quello di Robert Bloch, Stephen King e Peter Straub alle ubriacature minimaliste di Bret Easton Ellis, fino alle contaminazioni cinematografiche delle mode splatterpunk di Clive Barker. L’Italia raggruppa pochi e radi autori, dai giganti come Umberto Eco e Fruttero & Lucentini, a nomi come Roberto Vacca, Maurizio Cohen, fino all’esordio di Paola Capriolo, o la figura appartata di Tiziano Sclavi.
Siamo negli anni della giovane narrativa italiana di De Carlo e Tondelli, a cui seguirà la giovane narrativa dei ’90, affascinata dalle mode del pulp ibridato con un’analisi sociale spietata e tagliente. Nella Guida alla letteratura horror di Odoya (2014) si ricostruisce in poche pagine la linea rossa della letteratura di genere italiana, dai fuochi postunitari della Scapigliatura (attratta dall’onirismo romantico e dai trattati patologici degli anatomisti), fino al fantastico colto praticato da autori assortiti come Giovanni Papini, Guido Gozzano, Luigi Pirandello, fino ai più convinti Dino Buzzati, Tommaso Landolfi e Mario Soldati. A fare da ponte tra queste scritture e quelle odorose di cantina dell’editoria da edicola, si colloca la figura inclassificabile di Emilio de' Rossignoli, sottratto all’oblio da studi recenti e appassionati. Tra gli italiani contemporanei figure personali (e tra loro diversissime) sono quelle di Michele Mari, Valerio Evangelisti, Alda Teodorani, Gianfranco Nerozzi, Eraldo Baldini, Niccolò Ammaniti, Andrea Morstabilini, tanto per citarne alcuni.
Negli anni ’80 però, ad ubriacatura appena finita, il romanzo di genere pare entrare in una sorta di letargia e ripensamento che fatica a confrontarsi coi fasti degli anni ’60, con quella grande abbuffata di editoria da edicola che ha canonizzato una scrittura sotterranea e alternativa rispetto a quella ufficiale dei grandi editori. A parte la figura isolata di Tiziano Sclavi (i cui romanzi sono composti quasi interamente tra la metà dei ’70 e i primi anni ’80, anche se poi vedono la luce quasi tutti nei primi anni ’90) escono, nel giro di pochi anni (’84 – ’87) tre romanzi molto belli e originali, accumunati dalla medesima tematica di fondo, quella del vampirismo. Me ne interessa uno in particolare, il primo, ma sbrigherò anche gli altri due. Il primo è Anemia di Alberto Abruzzese, pubblicato nel 1984 da Theoria. L’edizione originale ha la forma di un libretto color vinaccia, anonimo, senza alcuna illustrazione, simile nella forma a un libretto parrocchiale. In realtà contiene una novella originale che ripensa radicalmente i canoni del vampiro, pur allacciandosi al passato recente di tanta narrativa di genere. La storia si apre sul rapporto sentimentale di un dirigente del partito comunista (tale Umberto U) con la sua amante Marcella. Umberto è un dirigente disilluso, fiaccato da un malessere psicologico e fisico che trova i segni di una anemia inspiegabile. Un’anemia che lo condanna a osservarsi dall’esterno, disinteressato a seguire le riunioni di partito, le discussioni interminabili e i lavori di un Palazzo del potere che è ancora quello imperscrutabile descritto dal Carlo Levi dell’Orologio o dalle parabole enigmatiche di Leonardi Sciascia.
L’anno in cui Alberto Abruzzese colloca il romanzo non è un anno a caso: siamo nel 1984, in una Prima Repubblica che ancora si crede viva ma è già un cadavere anemico pronto a dissolversi. Mentre Umberto simula nelle prime pagine del romanzo una quotidianità lavorativa a cui ormai si sente sempre più estraneo, attorno a lui scorre un mondo moderno, un brulichio elettronico di schermi, strade congestionate; l’ombra del terrorismo ha quasi concluso la sua parabola di morte, spenta dagli arresti di massa, da centinaia di morti e sopravvissuti psichici gettati nelle paludi delle carceri speciali. Intanto il paese vede esplodere proprio in questi anni il suo debito pubblico, mentre fabbriche storiche come la Olivetti non sono più in grado di reggere la concorrenza globale. Sotto la superficie luccicante di affari e rampantismo emerge il disincanto di una generazione vacua e disillusa di cui Umberto U fa pienamente parte. Non c’è più spazio per il mondo anarchico e libertario del decennio precedente. Berlinguer muore proprio in quell’84 portando nella tomba la strana pretesa di un partito autonomo e fermamente democratico, capace di non essere un partito fantoccio dell’Urss e di dissociarsi dagli orrori del comunismo sovietico. L’autonomia di quel Pci, le sacre narrazioni collettive e le ideologie di quegli ultimi anni sarebbero crollate con la fine della guerra fredda. Anemia è una fotografia precisa a un passo dalla dissoluzione di Mani pulite, quando ancora le ultime evanescenti figure vampiresche del potere si aggirano nei meandri oscuri dei palazzi di un potere che riesce ancora per un po’ a sopravvivere all’anatema di Pasolini.
In Anemia ormai sono tutti morti, o a un passo dall’esserlo, personaggi stonati e storditi che fingono una quotidianità di cui han perso il senso e il gusto (un po’ come gli ultimi personaggi della commedia italiana ritratti da Scola nel mortuario La terrazza del 1980, sorta di apologo su dei non morti rancorosi e apatici, ultimi epigoni di una dolce vita in dissoluzione). Così, tra colleghi che si suicidano senza motivo, per sfuggire alla noia e al malessere che lo opprime, Umberto U si dilegua in un villino paterno, in un paesino dell’infanzia in cui rinviene il diario di un nonno di cui quasi non serba memoria. E qui apprende di una tara di famiglia, una maledizione borghese che affonda le parole nei meandri di un’inquietudine lontana dai fastidi dei segnali elettronici. Spezzando la narrazione principale, Abruzzese, con una prosa concentrata e rapsodica, ci guida nelle parole del nonno di Umberto U, in una vicenda fosca e turpe che recupera a piene mani un mondo lunare e grottesco, una fantasticheria non lontana dalle nebbie lombarde della scapigliatura o dalle pagine febbricitanti dei Racconti di Dracula.
Scorre sotto i polpastrelli la Milano e la provincia degli anni ’30, quella degli anni ’40 dell’immediato dopoguerra, in uno sbandamento democratico che rievoca gli orrori della guerra e la maledizione di una zingara. Umberto U apprende così di una storia famigliare di profanazioni di tomba e ricordi personali dimenticati prima di tornare a deambulare tra le risonanze e gli ultimi bagliori di un mondo parallelo in cui, alle elezioni europee di giugno, il partito comunista raggiunge il suo ultimo apice. Il romanzo si chiude sul deambulare del protagonista, sulle sue fantasticherie erotiche, fino all’imbambolarsi dentro i balenii spettrali di uno specchio. Con una prosa controllata e sonnambula, Abruzzese ci consegna una fotografia livida di un paese di passaggio, una stagione incerta di depressioni e follie (le stesse raccontate, in ambiti metropolitane dallo Sclavi di Nero), una crisi esistenziale che si riflette in quella del socialismo sovietico, mentre il Berlinguer ultimo teorizza con coraggio le prospettive di una fine della guerra fredda e di un superamento dei blocchi, sognando un nuovo ordine mondiale nella visione lucidissima di un’Europa come potenza civile e soggetto politico autonomo.
Nel 1987 Feltrinelli licenzia il terzo romanzo di Gianfranco Manfredi, Ultimi vampiri, una raccolta di racconti a tema vampiresco. Non ho mai posseduto questa versione e per leggere il lavoro dello scrittore milanese ho dovuto attendere la bella ristampa fatta da Gargoyle, editore che negli anni zero ha fatto una coraggiosa e originale riscoperta del genere horror nell’editoria di qualità. L’edizione della Gargoyle aggiunge un ottavo racconto ai sette originali, oltre a un lungo inedito (praticamente un romanzo breve) a chiudere la nuova raccolta. In Appendice vengono proposti tre saggi, uno che già compariva nell’edizione Feltrinelli, gli altri due inediti.
Ultimi vampiri è un libro fortemente originale (come tutta la produzione letteraria di un autore singolare come Manfredi, cantautore, scrittore prolifico di fumetti, sceneggiatore cinematografico, sicuramente insieme a Sclavi una delle personalità più complete emerse negli anni ’80) che, come spiega Tardiola, offre una sorta di ricapitolazione narrativa del folklore legato alla figura del vampiro: dai luterani radicali della Moravia, ai cacciatori di vampiri pre-illuministi, alle paludi purulente di Versailles, fino alla Hollywood onirica di Lon Chaney e Bela Lugosi, Manfredi varia sapientemente il suo registro linguistico muovendosi tra ragione e immaginazione pura. Ultimi Vampiri è un affresco storico e grottesco che sembra anticipare i pastiche fantastorici di Valerio Evangelisti.
L’edizione Gargoyle è arricchita dal romanzo completamente inedito Summer of Love, cavalcata che dagli anni ’60 arriva praticamente ai nostri giorni. Qui la prosa di Manfredi si discosta dai precedenti racconti per farsi pulp e scanzonata. Tuttavia la ricostruzione storica dei decenni più lunari della nostra horror si immerge a piene mani in quel calderone esoterico e satanico che la psicosi liberatrice degli anni ’60 ha scoperchiato: tra motociclisti fracassoni, piccoli delinquenti, oscuri signori della notte, fascinose vampire e non morti forzuti, Manfredi si abbandona all’ipnosi oscura dell’Era dell’Acquario, tra conquistatori lunari, accozzaglia di straccioni imputriditi fino al midollo di eroina, LSD, erotismo e libri di occultismo, in un mix talmente originale e spericolato da dare alla testa. Manfredi è uno scrittore capace di coniugare come pochi un fantastico puro con gli elementi classici di una narrativa e cinematografia horror.
I vampiri di Manfredi, a differenza di quello sperduto e inoffensivo di Abruzzese, portano dentro di sé un elemento di gioco letterario, di contraffazione colta e raffinata, una sorta di distacco parodistico che deve far parte della formazione dell’autore, troppo consapevole per credere fino in fondo a un modello consunto senza giocare a sovraesporre la credulità e la superstizione del passato al progresso tecnologico del presente. Prima di parlare di Jesi, spunti originali sul vampirismo sono trattati, in quel decennio, anche da un bel saggio di Fabio Giovannini, Il libro dei vampiri (Dedalo 1985). In una pagina Giovannini accenna al mito vampiresco accostato ai postumi del terrorismo: un primo riferimento è a Beniamino Placido che immagina i vampiri visitare il popolo terrorista che dorme nelle prigioni, ispirandoli a scrivere proclami contro i succhiasangue delle multinazionali; in un altro articolo di Guido Gerosa, apparso in un numero di Penthouse del gennaio ’83, si accosta l’immagine della donna vampira a quella delle terroriste, “perché la donna terrorista sembra recuperare le qualità più arcane attribuite alla donna dalla letteratura: mutevolezza, segreto, perfidia, crudeltà, instabilità, ansia di potere, ribellione, affermazione violenta (…) come l’antica maga dei canti classici, hanno una levigata immagine di bellezza dietro la quale si cela la grinzosa maschera della vecchia cadente e il volto perduto dell’orrore. Ma è proprio da questo loro indecifrabile poema, da questa fascinazione erotica misteriosa che le avviluppa che dobbiamo cominciare a svelare l’enigma oscuro del nostro tempo”. A tornare su questi sentieri interrotti è il bel saggio di Vito Teti (Donzelli 2018), che in un’ultima e inedita sezione, affronta la postmodernità del mito vampiresco, inserendolo nel contesto della globalizzazione e del crollo simbolico delle Torri gemelle, dove al terrorismo rosso si è sostituito quello fondamentalista; altra suggestione elaborata da Teti è quella del corpo-paese dissanguato, spopolato, abbandonato, simile a un defunto irrequieto da placare e ricontestualizzare nella memoria spezzettata del nostro presente1.
Ed eccoci all’ultimo autore che affronta la tematica vampiresca: Furio Jesi. Confesso di non saper nulla di Jesi, inoltre i suoi interessi, i suoi studi da germanista mi lasciano indifferente. Di lui ho sentito parlare a margine in alcuni testi sul vampirismo, senza mai rintracciare nulla. L’editore Aragno, senza che me ne accorgessi, ne ristampò uno, il più importante. La copia finì fuori catalogo, condannandomi ad altri peregrinazioni. Infine sono finalmente riuscito a mettere le mani sulla prima edizione de L'ultima notte, romanzetto edito da Marietti nel 1987, lo stesso anno di Manfredi. Il libro ha genesi lunga e fumosa. Anzitutto Furio Jesi (altro torinese marginale, come noterebbe il nostro Max Boschini) aveva già detto qualcosa di originale sul tema, scrivendo nel 1960 La casa incantata (uscito postumo nell’82 per Vallardi), una strana favola che mescola un viaggio fantastico, credenze magiche, oggetti parlanti e un mondo lunare che anticipa forme e figure del romanzo successivo.
L’ultima Notte, nell’avvertenza dell’Editore, è un manoscritto a cui Jesi ha lavorato dal 1962 al 1970. Trattandosi di un romanzo vampiresco assai originale viene da domandarsi da quali fonti sia partito lo scrittore torinese. Certe somiglianze rimandano al classico di Matheson Io sono leggenda, tradotto da noi per la prima volta da Longanesi nel ’57. Chissà poi se la trasposizione cinematografica del ’64 ha in qualche modo dato altra benzina a Jesi? In realtà le coincidenze tra Matheson e Jesi si esauriscono nella forma distopica delle due narrazioni.
In Jesi l’umanità è minacciata dal mondo notturno dei vampiri, figure mitiche ridotte ai margini del mondo, costretti a vivere nei sotterranei e tra le rovine, sconfitti e domati nei millenni dagli uomini e dalla loro civiltà tecnologica. Ora i vampiri (esseri dall’aspetto umano ma che umani non sono mai stati, coaguli folklorici che affondano tra l’Assiria e Babilonia, fino alle remote terre d’Arabia) decidono di unirsi e riprendere il controllo dell’umanità; così dalle cantine buie e ammuffite, dalle fognature che collegano tra loro le dimore dimenticate di queste civiltà, i vampiri risalgono in superficie e scatenano una guerra originale contro il genere umano, destinato a trasformarsi in una riserva illimitata di sangue fresco.
Questo il romanzo da una parte, dall’altra altri personaggi umani e curiosi, ultimi epigoni di un’umanità dai toni adolescenziali che rimandano a certe favole nere di Bradbury: il grande poeta, Faraqàt il giocoliere del teatro delle ombre, il consigliere Moriqì e figure di Santi e chierici che si intromettono nell’agone, trascendendo e mescolando i confini del fantastico e del reale. Jesi scrive una favola per adulti, un romanzo diviso tra luci e ombre, tra speranza e annientamento, dove vampiri e umani non mi paiono poi così opposti, impasti metaforici che si scontrano sullo sfondo di città deserte e solitarie e dentro ai quali Jesi proietta e indaga studi e mitologie di una vita. Jesi, a differenza di Matheson, è indefinibile.
Già, gli anni in cui si muove, in cui scrive e lavora a strati sui romanzi dei vampiri sono quelli delle neoavanguardie italiane, della letteratura automatica dei Racconti di Dracula, alto e basso a cui Jesi aggiunge i suoi interessi archeologici. Tuttavia, nello scontro irrisolto e sospeso tra l’umanità e la sua controparte fantastica, Jesi sembra attirato dalle descrizioni seduttive della notte e delle rovine, dove tra polvere di bottiglie e scantinati in demolizione sopravvive un lanoso strato di stupore infantile, il bisogno di cibare una fantasia primordiale, una fanghiglia letteraria che macina e tritura i vampiri di cartapesta del cinema (un Dracula obsoleto, comatoso) ai grifoni politeistici di qualunque religione che s’è affacciata sulla terra.
La sensazione è che Furio Jesi, pur terminando un romanzo in chiaro, d’una lingua tersa, leggibilissima, godibile, priva di difficoltà, scriva in realtà d’altro, pensi e veda altro. Come lo Sclavi ultimo degli zombi in Dellamorte, affacciato ironicamente sugli abissi della sua dissoluzione come scrittore, qui Jesi gioca coi materiali disparati della cultura vampiresca per mettere in scena quel che non si capisce se è un’apocalisse (mi viene in mente che uno studioso come Franco Pezzini, negli scontri di piazza sotto la Torre Littoria di Torino ci vede trasposti forse gli scontri di piazza che si andavano consumando in quegli anni), o una rinascita, o soltanto una recita (come già la sensazione di fondo alla lettura della Casa Incantata), una pantomima di burattini e noci di galla intagliate. Rimane il fascino di un romanzo in cui (e qui torniamo alle note di fondo di questo pezzo) si avverte un’urgenza e un bisogno quasi privato nella scrittura, qualcosa di lontanissimo dalle traiettorie narrative di genere di oggi, dai romanzi costruiti a tavolino (nel bene e nel male) dagli editor delle case editrici. Jesi, Abruzzese e Manfredi, si muovono ancora fuori dai perimetri convenzionali della scrittura.
- In questo breve percorso sulle scritture di genere degli anni ’80, mi accorgo che manca all’appello il nome di Scalvi. L’autore milanese ha lasciato la sua interpretazione del tema in vari albi della collana Dylan Dog. In particolare mi viene in mente il numero I vampiri uscito nel novembre del ’91: alla sua maniera Sclavi riassembla spunti eterogenei e costruisce una storia allucinatoria dove i vampiri hanno invaso il mondo e si sono mescolato agli umani, dominandoli e colonizzandoli in modo silenzioso, annichilendo la libertà in favore di un consumismo letto sempre in chiave negativa e distopica. Pessimismi a parte, Sclavi, in questi anni (altro numero importante Caccia alle streghe, di poco successivo) legge e tramuta le incertezze (e la violenza) di una stagione di passaggio in cui la Prima Repubblica crolla sotto i colpi dell’inchiesta di Mani Pulite, svelando un potere e una politica che da allora viene vista in modo negativo come forma di arricchimento personale e arroganza della piccola e media borghesia. Un clima feroce e di sospetto sembra aleggiare su quei primi anni ’90, clima aggravato da una grave crisi della lira, dalle bombe della mafia. In questo clima di paura e ombre, Sclavi soffia sulle paure complottiste o inscena, in modo originale, nuove cacce alle streghe, ragionando sulle campagne di stampa condotte contro certa editoria horror del periodo. Come nota Fabio Camilletti c’è un filo rosso che collega i libri usati, i volumetti dei Racconti di Dracula, i KKK, gli Edifumetto, fino agli Splatter e ai Dylan Dog, ultimi bagliori di stagioni irripetibili che trovano un loro fiammeggiante e disperato epilogo proprio in quei primi anni ’90.